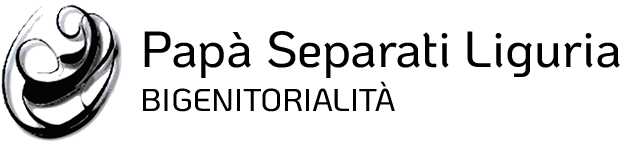Cassazione N.15111/2010 – Se minaccia la moglie commette estorsione
Sempre più spesso, purtroppo, le difficoltà che emergono nel contesto dei rapporti familiare assumono un rilievo tale da trasmodare in profili di ordine penale.
La sentenza 20 aprile 2010, n. 15111 pronunziata dalla IIa Sezione della Corte di Cassazione affronta il tema della ravvisabilità del reato di estorsione nel comportamento del coniuge che rientri nella disponibilità della casa familiare, utilizzando minacce nei confronti della parte cui la stessa sia stata assegnata nel corso del giudizio di separazione o di divorzio.
Va detto subito, onde evitare equivoci, che anche in un caso particolare – in fatto – come quello oggetto della pronunzia citata, la struttura, sia materiale che formale, del delitto di cui all’art. 629 c.p., non soffre significative alterazioni.
Emerge, infatti, prima facie un’azione illecita connotata dall’elemento della minaccia, azione “volta ad ottenere un comportamento immediato del soggetto passivo, influendo sulla sua libertà di autodeterminazione” (Cfr.Trib. Napoli Sez. III, 8 aprile 2004, Riv. Pen., 2005, 599).
Il marito condannato avrebbe – infatti – posto in essere, in modo ritenuto sia dai giudici di merito, che di legittimità, sufficientemente ed adeguatamente provato, plurime minacce di morte per ottenere il rilascio dell’immobile e riprenderne il possesso materiale.
Sarebbe, quindi, stata posta in essere un vis psichica, che suppone nei confronti del destinatario della minaccia la prospettazione di un danno futuro (che può essere anche in sé non ingiusto).
Risulta, pertanto, nodale l’affermazione che è la minaccia di “un male” l’in sé negativo della condotta (Cfr. MARINI Voce Estorsione in Digesto Discipline Penalistiche vol. IV pg. 376).
Va, però, sottolineato come la presenza della minaccia, in sé, non pare sufficiente a permettere di concludere per la configurazione piena ed inequivoca del delitto di estorsione.
L’elemento costitutivo della minaccia (o della violenza), per potere esplicare appieno quella valenza antigiuridica, che connota di illiceità la condotta dell’agente e le rende sussumibile nel nomotipo di cui all’art. 629 c.p., deve produrre concretamente una coartazione“…preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto…” [Cfr. Cass. pen. Sez. V, 19 aprile 2006, n. 32011 (rv. 235195), Procuratore Generale della Repubblica presso Corte Appello di Cagliari c. A.R., CED Cassazione, 2006, Riv. Pen., 2007, 9, 921].
E’ gioco forza, quindi, affermare che la condotta materiale – idonea a suscitare privazione della libertà di autodeterminazione nelle disposizioni patrimoniali del soggetto passivo – deve trovare, quindi, naturale e consequenziale risultato nella verificazione dell’ingiusto profitto del minacciante e del correlativo danno del minacciato.
E’ in tale ulteriore sviluppo ed approdo dell’azione che l’estorsione si manifesta distinta dalla violenza privata di cui all’art. 610 c.p. .
Ha, infatti, affermato la Suprema Corte, Sez. II, 18 novembre 2005, n. 44319, (Terrenghi, Giur. It., 2007, 1, 196 nota di MARTINELLI) che il reato previsto dall’art. 629 c.p. “è una violenza privata caratterizzata dall’ulteriore evento del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno, caratterizzata dalla privazione della libertà di autodeterminazione nelle disposizioni patrimoniali del soggetto passivo”.
La centralità e decisività dell’ingiusto profitto viene valorizzata dalla Corte, stimolata sul punto dal ricorso della difesa, la quale ha proposto l’assunto che tale requisito non sia ravvisabile, atteso che l’immobile non sarebbe stato di proprietà della parte offesa.
E’ evidente che il danno in parola deve essere collocato nella prospettiva di carattere eminentemente patrimoniale.
Il MARINI (Estorsione cit. pg. 386) conferma questo indirizzo.
L’Autore parte da una valutazione di ordine sistematico, passa per l’esame della terminologia usata dal legislatore, che differisce rispetto ad altre distinte ipotesi di reato ove si parla di “vantaggio” od “utilità”, oppure “profitto”, per pervenire alla conclusione che si deve identificare il profitto “in termini rigorosamente patrimoniali cioè in termini di arricchimento o di mancato impoverimento del soggetto attivo…”.
Vale a dire che, muovendo dal principio che l’ingiusto profitto deve essere inteso “come accrescimento patrimoniale in senso lato” (Cfr. Trib. Bologna Sent., 25 gennaio 2010, Ve.Ar., www.leggiditalia.it, che sviluppa il concetto in relazione al reato di truffa ex art. 640 c.p., ma che offre un paradigma assolutamente pertinente).
Attesa questa premessa il profitto ingiusto è, dunque, quello contra jus oppure quello sine jure.
Qualunque situazione o condizione giuridica soggettiva che sia produttiva di effetti di carattere economico è, dunque, suscettibile di venire ricompreso nella nozione in disamina.
Assolutamente corretta, quindi, appare la posizione assunta dai giudici di legittimità, i quali risolvono il quesito posto, disancorando il concetto di profitto ingiusto da quello di ablazione del diritto di proprietà del bene in contesa.
Vine, infatti, così conferito valore di natura economico-patrimoniale anche al diritto di abitazione, dell’immobile, quale concreto esercizio del provvedimento di assegnazione giurisdizionale intervenuta nel procedimento di separazione o di divorzio.
Sinallagmaticamente è, quindi, ravvisabile anche il danno che la parte offesa viene a subire e che consiste nel mancato godimento di un bene, rispetto al quale il possessore era munito di un titolo valido e non revocato giudizialmente.
Tale danno non presenta profili meramente formali, quanto piuttosto abbina al naturale danno da reato anche un danno patrimoniale che consiste nella ablazione (quale effettivo danno emergente) di un diritto soggettivo (suscettibile di quantificazione economica).
Da ultimo appare opportuno rilevare che la Corte non esclude che nella fattispecie si potesse configurare in alternativa al reato di estorsione quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell’art. 393 c.p..
E’ pacifico che “Il criterio distintivo tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nel fatto che, mentre nel primo l’agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la consapevolezza che quanto pretende non gli è giuridicamente dovuto, nel secondo, invece, l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente. (Cfr. Trib. Napoli, Sez. IV, sentenza 8 febbraio 2010, K. N. V.,www.leggiditalia.it).
L’analisi che si impone usualmente per potere discernere dai fatti la corretta qualificazione di diritto, involge usualmente l’elemento psicologico dell’agente.
Nel caso concreto, come rilevato dai giudici di legittimità, la derubricazione ipotizzata avrebbe potuto avere un proprio pregio, a condizione che fossero indicate le reali ragion di diritto.
Ciò in concreto non è avvenuto e, dunque, l’argomento rimane puramente potenziale.