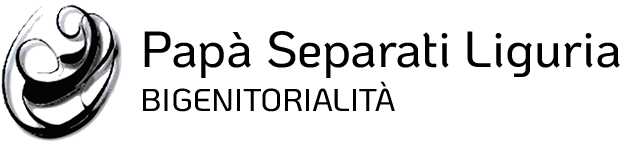Separazioni: la disuguaglianza di genere che condanna gli uomini
Il diritto di famiglia (non tanto quello scritto dal legislatore quanto quello poi interpretato e stravolto dalle corti di giustizia, attraverso prassi che violano sistematicamente l’inviolabileprincipio di uguaglianza) è culturalmente retrogado ed ancorato a stereotipi validi perlomeno fino agli anni ’60, quando l’uomo deteneva il potere (economico) e la donna gestiva e quasi monopolizzava il rapporto con i figli. Un modello che all’esterno poteva apparire patriarcale ma che occorrerebbe pure ridefinire: era veramente predominio dell’uomo o in realtà dominato dalla donna che ne deteneva il potere familiare?
Un diritto di famiglia – quello declinato dalla giurisprudenza con prassi aberranti tali da creare diseguaglianze devastanti – nel quale la donna spesso è l’asso pigliatutto: casa familiare (anche se di proprietà esclusiva dell’uomo ed anche se egli continui a pagarne il mutuo); mantenimento (per sé secondo la formula vuota del “tenore di vita” goduto in costanza del matrimonio come se questi sia immutabile nel tempo e tale da costituire una rendita vitalizia); figli, goduti temporalmente in modo abnorme (85%) e diseguale rispetto all’uomo (15%) e mantenuti dall’uomo secondo parametri virtuali che non corrispondono in alcun modo alle esigenze del mantenimento reale.
L’uomo diviene quindiun attore non protagonista, uno spettatore pagante, ridotto allo stato larvale attraverso provvedimenti giurisdizionali di spietata disuguaglianza, di grigio cinismo e di rara ottusità. Pagare e non toccare, pare il mantra tramandato dagli antichi (giudici) agli attuali, acritici.
Tutto ciò è il frutto deforme di una cultura che permea il pensiero, dunque l’azione e la condotta dei giudici (non di tutti certo, a Milano ad esempio v’è in tribunale la sezione specializzata del diritto di famiglia composta da giudici molto competenti ed equilibrati): cultura che indica nella donna il soggetto debole (e vittima) a prescindere e nell’uomo il soggetto forte (e carnefice) a prescindere. Una cultura che delinea la presunzione di colpevolezza dell’uomo.
Vi farò un banale esempio. Immaginate un grattacielo e un ascensore in cui salgono al pian terreno una donna ed un uomo, durante la risalita la donna fa avance all’uomo che però rifiuta, lei si sente offesa e poco prima dell’apertura delle porte si vendica del rifiuto e improvvisamente all’apertura delle porte si sbaffa il rossetto e si strappa parte del vestito e urla, indi le porte si aprono davanti a decine di persone. Cosa accadrà? In un secondo lo giudicheranno un presunto stupratore e lo aggrediranno fisicamente. Immaginate la scena a parti inverse. Cosa accadrà? In un secondo le persone lo guarderanno perplesso, alcune rideranno.
In questa ebbrezza della cultura della disuguaglianza di genere (termine che mutuo volutamente), che domina costantemente il diritto di famiglia e le aule di giustizia, si consumano quotidianamente soprusi e violenze (dei sacri diritti) nell’assordante silenzio generale, mentre al di fuori domina l’ipocrisia della “cultura di genere” e delle quote rosa, oramai mero strumento di assalto ad ogni governance senza confrontarsi col merito e senza transitare attraverso il suffragio universale.
In ciò spesso prevale anche il sentimento della vindicatio come emerge palesemente dagli scritti di Maria Luisa Rodotà, la quale nella sua rubrica sul Corriere della Sera incita sempre le donne a “non prendetevela, prendetevi tutto!”, come se famiglia e rapporto di coppia siano terreni dove è necessario armarsi, distruggere e umiliare l’avversario.
Fortunatamente la giurisprudenza mostra segni di ravvedimento. Infatti poco fa sono state depositati due provvedimenti che indicano un incipit di svolta culturale. Nel primo caso è stato ritenuto legittimo che il tribunale nella quantificazione dell’assegno di mantenimento desse prevalenza alla breve durata del matrimonio e non alla differenza reddituale tra i coniugi (Cass., sez. VI, ord. 11 luglio – 4 settembre 2014, n. 18722). Nel secondo caso è stato ritenuto legittimo il diniego del tribunale (poi confermato in appello), al trasferimento della madre con il figlio ad una distanza tale da compromettere il rapporto padre-figlio e l’esercizio del diritto genitoriale (Cass., sez. I, 18 settembre 2014, n. 19694). Due pronunce importantissime al cospetto di migliaia di casi già decisi in modo però diametralmente opposto. Uno spiraglio di giustizia dinanzi a enormi ingiustizie.
Avv. Adriano Mazzola
Fonte : http://www.ilfattoquotidiano.it/