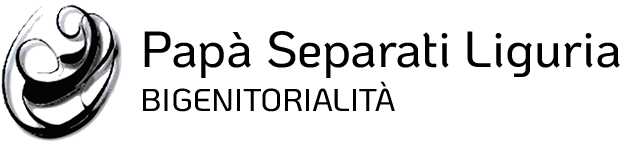DDL 832 – In arrivo il vero affidamento condiviso? Ancora di fronte Tolomeo e Copernico
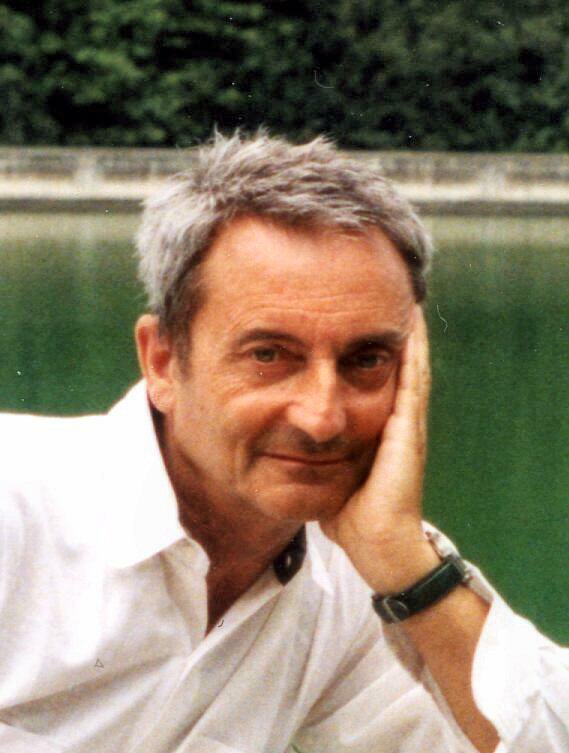
Fonte: Osservatorio della famiglia
In arrivo il vero affidamento condiviso? Ancora di
fronte Tolomeo e Copernico
Marino Maglietta
Seguendo le cronache mediatiche, oggi come un tempo – quando fu introdotto – si può avere l’impressione che l’affidamento condiviso dei figli sia un istituto che divideva e divide in due il paese principalmente sotto l’aspetto del genere: padri contro madri, se non addirittura donne contro uomini, quale ribellione al patriarcato. E non mancherebbe, di conseguenza, una contrapposizione politica ancora più drastica, benché sottintesa: da una parte i conservatori, dall’altra progressisti.
Niente di più errato. Effettivamente l’affidamento condiviso divide, ma non nel senso descritto. Si tratta di un istituto (come era stato pensato) che può essere accolto con estremo favore o con estrema riluttanza, ma non per categorie intere, come vorrebbe il messaggio che alcuni si sforzano di costruire. In realtà, non si può che dissentire dal modo in cui le categorie vengono create. Le madri sono divise, i padri ugualmente. Madri illuminate che vorrebbero il supporto dell’ex nella cura dei figli e non lo ricevono sono alleate naturali dei padri che vorrebbero essere presenti (un numero rapidamente crescente), ma trovano insormontabili ostacoli in madri sedotte dal miraggio dell’assegno che la giurisprudenza attribuisce al genitore prevalente e che pratica la maternal preference. E la politica esibisce profondi sconvolgimenti che giungono fino alla prevalente inversione della tradizionale attribuzione dei ruoli. Fautori e detrattori albergano un po’ ovunque, anche se indubbiamente si possono individuare talune tipicità.
E tuttavia per l’attento osservatore una discriminante esiste ed è implicita in quanto appena detto. L’affidamento condiviso – così come è stato pensato da chi scrive e varato a suo tempo dal Parlamento – presenta norme destinate ad incidere fortemente sulla struttura sociale del paese e pertanto i suoi fautori e i suoi detrattori si dividono anzitutto in funzione degli effetti concreti che può produrre: ovvero della specifica, particolare convenienza. Che a sua volta porta alla politica, oppure no, un ben preciso consenso.
I fondamenti dell’affidamento condiviso
In estrema sintesi, l’affidamento condiviso, definito un tempo “rivoluzione copernicana”, strettamente fedele alla Costituzione nell’enunciato dell’articolo 30, che non fa distinzioni di genere tra un genitore e l’altro, tra madri e padri, richiama questi ultimi a pari doveri e pari responsabilità. La rivoluzione sta – o stava – tutta qui. Come salto verso la bigenitorialità a partire da un modello a genitore prevalente. La “tradizione”, che congela la società secondo modelli stereotipati – madri accudenti e padri procacciatori di reddito – dovrebbe appartenere al passato. Ma è un passaggio non ancora compiuto; a dispetto dei circa venti anni trascorsi dalla sua introduzione.
In pratica, Copernico aveva vinto la battaglia legislativa, ma Tolomeo ha continuato a trionfare sul campo. Genitori entrambi affidatari discriminati in “collocatario” e “non collocatario”. Il primo investito da prevalenti compiti di cura e poteri decisionali; il secondo chiamato ad erogare assegni e ad esercitare – se ne ha la propensione – il cosiddetto marginale “Diritto di visita”. Con una altrettanto forte asimmetria di genere: collocatarie le madri, non collocatari i padri. Il che aggiunge danno al danno, perché sbilanciare le aspettative in sede giudiziaria brucia le possibilità di intesa extraprocessuale e di soluzioni mediate. Una situazione – ovvero il rigetto della riforma da parte del sistema legale – delineatasi immediatamente dopo i primi mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa, per cui già l’8 febbraio 2007 venne depositato il primo testo (pdl 2231) che intendeva sanare le difformità tra legge e prassi a favore della prima. E da
allora ininterrottamente si sono ripetuti i tentativi, tutti della stessa matrice, con l’unica eccezione del ddl
735 della scorsa legislatura, di impianto e contenuti del tutto diversi.
Fino al più recente, il ddl 832, oggi al vaglio della Commissione Giustizia del Senato. Già sono iniziate le audizioni e già ne è iniziata l’assalto da parte dei ”tolemaici”, per altro ben supportati a livello mediatico. Non appaiono valide, tuttavia, le argomentazioni portate, che essenzialmente traggono spunto da un travisamento (o involontario equivoco) dei contenuti della proposta, oltre che da previsioni di danni futuri di discutibile credibilità. Il testo, depositato in una prima versione nell’agosto 2023, è stato oggi pubblicato in forma abbastanza modificata e può essere agevolmente consultato dal lettore. In questa sede, pertanto, appare più utile rendere conto dello stato dell’arte, costruendo una sorta di contraddittorio a distanza. Una sintesi perfetta, pressoché completa, delle obiezioni mosse al progetto è rinvenibile nell’audizione in Senato della Garante Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, le cui tesi pertanto vengono qui di seguito riportate, accompagnate dalle opportune precisazioni. In questo modo è probabilmente più facile far
capire ciò a cui teneva il grandissimo poeta ligure “ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”
Rassegna dei punti più qualificanti
Una bigenitorialità male intesa, una parità dei tempi sempre e comunque –
“Un abito su misura cucito di volta in volta, caso per caso e con tutta la necessaria flessibilità a vantaggio dei figli, e non un diritto dei genitori a una spartizione perfetta o quasi perfetta, due vite, due case. La Corte di Cassazione lo precisa: affido condiviso e bigenitorialità non coincidono necessariamente con eguali tempi di permanenza con ciascun genitore.” E a sostegno della tesi più avanti aggiunge: “… nell’introduzione si menziona l’ordinanza 26697/2023 della Corte di Cassazione là dove afferma che “il regime legale dell’affidamento condiviso (…) deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio”. Ma si omette significativamente di citare il passaggio successivo – che sposta decisamente l’asse del discorso – dove si dice “che tuttavia nell’interesse del figlio il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita”.
Banalmente, se si cita solo la prima parte della tesi di Cass. 26697 è perché questa è già sufficiente a dimostrare che la parità nella frequentazione è solo la regola, l’ipotesi da considerare prioritariamente, dalla quale ci si può certamente discostare in presenza di “gravi ragioni ostative”, ovvero di eccezioni ragionevoli. Come la distanza tra le abitazioni, la tenera età dei figli o impegni lavorativi imprescindibili dei genitori (il padre camionista, la madre assistente di volo ecc.). La critica dunque sarebbe fondata se il ddl contenesse ciò che gli viene attribuito. Ma così non è.
Il primo comma dell’art. 337 ter c.c. contiene le enunciazioni di principio, ovvero scandisce la scala delle priorità che devono guidare le scelte del giudice, mentre le modalità attuative sono collocate al secondo comma, fermo restando il rispetto per quanto possibile dei principi già stabiliti (“Per realizzare le finalità di cui al primo comma …”. Pertanto la norma richiama entrambi i genitori a un pari impegno e pari responsabilità e sacrifici per i figli. Quanto alla frequentazione, non si parla di parità, ma di pari opportunità, che sono attribuite ai figli, non ai genitori. Ovviamente, queste esistono se i genitori hanno pari dignità, senza graduatorie e gerarchie. Il che vuol dire mandare in soffitta la distinzione tra genitore collocatario e non: del resto logicamente e giuridicamente incompatibile con un affidamento condiviso. In concreto, vuol dire che — escluse le eccezioni sopra esemplificate sulle quali il giudice può intervenire, senza rigidità ma anche senza l’attuale totale discrezionalità – il provvedimento indicherà un calendario paritetico rispetto al quale saranno istituzionalmente ammesse deroghe in funzione delle esigenze dei figli, ovviamente a partire da quelli adolescenti. Una flessibilità attualmente inesistente (salvo genitori entrambi illuminati, ma allora non servono né giudici né sentenze), proprio perché non esiste simmetria tra i genitori; il che brucia le opportunità di scambio. Ad una richiesta del figlio si risponde “Il giudice ha stabilito che tu stia qui, vuoi farci litigare?”. E l’altro genitore non ha nulla da offrire; i vantaggi della collaborazione non sono visibili. D’altra parte, volendo affrontare anche le situazioni dove la deroga dalla parità si impone già in partenza, in modo sistematico (come residenze distanti centinaia di km), lo spazio per farlo è offerto dal secondo comma, come già accennato. Il giudice
“determina le specifiche modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore” è affermazione che in generale serve per stabilire se di mercoledì il figlio si trova presso il padre o la madre e chi ce lo porta, ma anche, ove ce ne sia la necessità, per disporre frequentazioni asimmetriche. Esattamente quanto afferma Cass. 26697/2023 con la “parità tendenziale” della frequentazione quale regola, con le ovvie necessarie eccezioni.
Tutto ciò limitandosi a svolgere considerazioni puramente pragmatiche. Resta il fatto che la novità non c’è. Il diritto dei figli a un “rapporto equilibrato e continuativo” già di per sé conduce prioritariamente a una frequentazione paritetica, che mette “out law” la miriade di protocolli e prestampati distribuiti ai separandi nelle cancellerie, che esigono che si indichi a priori un “collocatario”. Ma come è possibile realizzare un rapporto “equilibrato” partendo da una presenza “sbilanciata”?
No alla doppia domiciliazione e al modello paritetico
La Garante, proseguendo, esibisce senza esitazioni né sbavature la sua schietta fede tolemaica proponendo le stesse critiche che vennero utilizzate all’inizio degli anni duemila per contrastare l’affidamento condiviso. Si mostra senza veli, esplicitamente a favore della monogenitorialità, ovvero dell’antico esclusivo. In sostanza, se i suoi argomenti fossero riconosciuti validi, il Parlamento dovrebbe tornare indietro di vent’anni. E tra le righe è esattamente quello che chiede. E’ importante, di passaggio, osservare che non fa mai riferimento alla legge 54/2006 e alla sue prescrizioni, ma ne sostiene l’opposto come se i principali contenuti del ddl 832 fossero novità da introdurre e non la conferma, e/ l’esplicitazione, di disposizioni già presenti. Ad es., se i genitori sono separati, il minore, ai sensi dell’art. 45 c.c., ha il domicilio del genitore con il quale convive. Una formula redatta ai tempi dell’affidamento esclusivo, ma che conserva la sua applicabilità anche oggi, in regime condiviso. Essendo affidato a entrambi i genitori il bambino vive presso entrambi, in tempi diversi, quindi è domiciliato presso tutti e due. Considerazione che non accetta chi, come la Garante, ragiona in termini monogenitoriali. Per cui neppure ci riflette. Non a caso, come si diceva, invoca le stesse antiche motivazioni: il “diritto” a fare i compiti sempre alla stessa scrivania, lo sballottamento tra due case, la stabilità logistica a danno di quella affettiva; e via dicendo. Fino a citare la testimonianza di un bambino che converge con le sue tesi. Peccato che un modello di frequentazione a settimane alternate comporti un solo spostamento in 14 giorni, a differenza di quello a genitore prevalente con w-e alternati più visite pomeridiane, che ne comporta cinque…
Sorvolando sulle innumerevoli indagini longitudinali (inevitabilmente estere, visto che in Italia il modello bigenitoriale è stato finora virtualmente ignorato) che da anni attestano i vantaggi educativi della bigenitorialità (ex pluris, H. Sunderhauf et al., 2013; L. Nielsen et al. 2014; R. Warshak et al, 2014), sarebbe stato interessante apprendere quali risposte darebbe la Garante alle osservazioni, e conseguenti richieste, che gli stessi figli ormai adulti di genitori separati hanno rivolto al Parlamento nelle due precedenti occasioni in cui sono stati convocati dalla Commissione giustizia del Senato (ass. Figli per i Figli e ass. Figli con i Figli, audizioni agli atti): tutte in linea con il ddl 832. Dichiarazioni alle quali può aggiungersi la testimonianza di Salvatore Palazzo, già presidente del Tribunale di Prato, che in sede di convegno ebbe a dichiarare che l’ascolto dei figli gli era risultato del tutto inutile, perché pressoché tutti gli dicevano di voler stare ugualmente con i due genitori.
L’unicità del rapporto madre-figlio e il no al paritarismo ideologico
Si è già chiarito che indubbiamente tra i seri motivi che giustificano la deroga rispetto alla pari presenza c’è la fase della vita nella quale è indispensabile la prevalenza materna. Quindi il diniego della Garante rispetto alla tenerissima età («la pratica del doppio domicilio è semplicemente impensabile») è condivisibile (anche se si confonde il doppio domicilio con la frequentazione paritetica), ma superfluo. Ella, tuttavia, va oltre: ”La bigenitorialità non può essere intesa come paritarismo che occulta la realtà della differenza sessuale”. E inoltre: “La bigenitorialità intesa come occultamento della differenza rischia di affermare un paritarismo ideologico a cui tuttavia nel
medesimo ddl non corrisponde poi il riconoscimento di una semplice parità di opportunità quando, mettendo sullo stesso piano il padre e la madre dal punto di vista del contributo economico per il mantenimento dei figli, non tiene conto del gap a livelli di occupazione e di retribuzione. Se è vero che stiamo registrando un record di occupazione femminile, è vero anche che il gap continua a esistere”. Una affermazione che con tutta evidenza anzitutto attribuisce ancora una volta prescrizioni che non vi compaiono (la proporzionalità del contributo alle risorse rispettive è intatto), ma sorvola sulla più diretta e logica conseguenza del pari sacrificio dei genitori nella cura dei figli, che pone rimedio alla penalizzazione delle madri separate costrette a barcamenarsi con estrema difficoltà per conciliare casa e lavoro: il raggiungimento di pari opportunità nel lavoro e quindi nella remunerazione, Di grande impatto anche sociale, in ambito nazionale. Detestando il ripetersi, basti rinviare agli studi dell’OCSE citati nell’introduzione. Del resto l’evidenza è lampante: schiacciare la madre nella solitaria cura dei figli la costringe ad effettuare scelte penalizzanti nell’attività esterna. Una critica da restituire al mittente.
No alla forma diretta del mantenimento
Altro pericolo segnalato dalla Garante verrebbe dal mantenimento diretto dei figli: “Eliminando l’assegno di mantenimento per i figli per passare, con il collocamento paritetico, al mantenimento diretto addirittura “per capitoli di spesa”, con un mini-bilancio, da parte di ciascun genitore durante la permanenza presso di lui, oltre a una casa più confortevole e una meno, potremo avere livelli di vita e di consumi da una parte più alti e dall’altra meno, con tutto ciò che ne consegue diseducativamente, anche questo in violazione del superiore interesse del minore e a vantaggio dell’adulto economicamente più forte”. E’ questo, forse, il punto di massima distanza tra critica e situazione reale, tanto che appare superflua una replica dettagliata. Il lettore può in larga parte effettuarla da solo. Pertanto, per sommi capi, si rammenta che la forma prioritaria del mantenimento è già, per legge, quella diretta e non l’assegno, che il quarto comma dell’art. 337 ter c.c. ammette solo in subordine. Come del resto ammette la Suprema Corte, da 23411/2009 a 26697/2023. In secondo luogo, il ddl non elimina l’assegno, ma gli lascia il suo ruolo perequativo, eventuale. In terzo luogo i tempi di permanenza non sono decisivi per la forma del mantenimento, che può tranquillamente essere diretto e per capitoli di spesa anche per tempi disuguali, essendo legate alle spese “esterne”. In quarto luogo il livello di benessere del figlio (abbigliamento, attività ludiche, istruzione, mezzi di trasporto ecc.) è ancorato, secondo il ddl, essenzialmente alle risorse complessive dei genitori e quindi non risente delle differenze tra l’uno e l’altro se non per l’ambiente dove ciascuno abita. Il che è ineliminabile. La lagnanza, per essere completamente sanata, richiederebbe un trasferimento non solo reddituale, ma anche patrimoniale all’interno della coppia, per parificarne le disponibilità: ovvero un cambiamento della Costituzione. Infine due parole in ambito non giuridico. La forma diretta è stata pensata e voluta per motivi relazionali tra genitore e figlio. Quest’ultimo non percepisce il trasferimento di denaro da un conto correte all’altro. Si accorge invece della cura che ciascun genitore gli dedica ed è altamente gratificante per lui che gli venga da entrambi attraverso la forma diretta. L’ “interesse del minore” interessa o si deve privilegiare quello di alcuni adulti?
No a restituire al figlio maggiorenne la piena dignità dell’adulto e problemi di natalità
Il dissenso si estende anche alle previsioni che riguardano il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente: “Al compimento della maggiore età e in caso di non autosufficienza economica, cioè praticamente sempre, il ddl riconosce la contribuzione diretta al figlio che difficilmente riserverà all’auto-mantenimento la somma percepita, impegnandola in attività più voluttuarie e aggravando ulteriormente il peso economico per il genitore più debole. Questa oggettiva disparità quasi sempre a svantaggio della madre comporta il rischio prospettico che quel sì, quel fiat con cui ogni donna accetta di diventare madre e senza il quale non vi è nascita a fronte di simili condizioni diventi sempre più raro. E allora non c’è piano di natalità che tenga, e conosciamo bene le dimensioni del problema della caduta delle nascite”. Anche in questo caso le repliche alle obiezioni sono plurime. Premesso che “contribuzione diretta” certamente si intendeva “versata direttamente nelle mani dell’avente diritto”, non si può che respingere quella sorta di pettegolezzo sulla immaturità dei figli maggiorenni. Non esiste alcuna indagine sociologica che lo attesti. Esiste invece una normativa che dà al compimento del diciottesimo anno il diritto di eleggere i deputati, contrarre matrimonio, comprare e vendere immobili e portare una pistola. E la Suprema Corte
(17183/2020) ha enunciato i principi di autoresponsabilità e prossimità, rispetto ai quali il ddl appare a chi scrive addirittura “timido” rispetto alla citata Cassazione, visto che difende l’autoresponsabilità, ma non ribadisce il principio di prossimità, in forza del quale l’onere della prova del diritto al sostegno è a carico del beneficiario e non dei soggetti onerati. Colpisce, inoltre, la sempiterna visione di una divisione tra due nuclei, madre con figlio e padre da solo, pur muovendosi da un affidamento condiviso. Cioè, ciò che si vuole è che il figlio debba chiedere le monetine alla madre ogni volta che vuole offrire un gelato (di più no, è voluttuario) alla sua ragazza. Senza contare che l’accordo interno al gruppo familiare è già previsto dall’art. 315 bis comma IV c.c. E’ ancora Tolomeo che parla. Non solo non si vuole che le cose cambino, ma si vorrebbe tornare indietro.
Quanto alla caduta della natalità quale esito di una preoccupazione femminile per ciò che accadrà 18 anni dopo l’eventuale nascita di un figlio a seguito di una eventuale rottura del legame, è previsione che chi scrive lascia alla Garante, confessando di non possedere un così lungo sguardo.
Pre-mediazione e mediazione
Curiosamente, sul punto della mediazione la Garante ne ammette l’utilità (una opportunità preziosa che può fornire una importante riduzione dei costi economici, umani e sociali delle separazioni) nonché che esiste la necessità di “diffondere la conoscenza di un istituto ignoto ai più e che i tribunali purtroppo offrono a macchia di leopardo”. Dopo di che, tuttavia – dopo avere rammentato requisiti come l’esclusione delle situazioni di violenza e la volontarietà che nessuno contesta – contesta radicalmente l’incontro preliminare alla mediazione: “L’idea di una pre-mediazione obbligatoria non è sostenibile. E nei casi di allegazione di violenza non è difficile che una delle due parti non ottemperi”. Non è comprensibile come si possa auspicare una maggiore conoscenza dello strumento e negare l’opportunità di un passaggio esclusivamente informativo, gratuito, con piena libertà di proseguire o meno, con possibilità di andarvi separatamente dall’altro in caso di timore e senza che la sua inadempienza costituisca impedimento a proseguire nell’iter giudiziario. Inevitabile pensare a una ostilità a prescindere, puramente ideologica.
Violenza e PAS
Un tema, quello della violenza domestica, insistentemente citato dagli avversari del condiviso per opporsi a qualsiasi tentativo di superare la discriminazione tra genitori collocatari e non, con il sottinteso – costante da parte di un certo tipo di femminismo – che il collocatario debba essere necessariamente la madre e che il genitore violento sia sicuramente il padre. Il che corrisponde ai dati statistici solo in termini di prevalenza, senza certezze, e con percentuali che potrebbero stupire. Soprattutto se si guardano i dati del Telefono Azzurro sulla violenza psicologica. Considerazioni che però porterebbero fuori strada, nel senso che, quand’anche i dati confortassero l’assunto di genere, l’inidoneità del genitore violento dovrebbe trovare sanzione a monte, con esclusione dall’affidamento condiviso, ai sensi dell’art. 337 quater c.c. Quindi non si può essere d’accordo con la tesi di fondo spesso ripetuta che l’affidamento non può e non deve essere paritetico perché esiste un consistente numero di genitori violenti. A parte il fatto che mortificare il ruolo di un genitore subordinandolo all’altro non lo fa certamente stare più tranquillo, mentre le occasioni per mostrarsi violento non gli mancano di sicuro anche se gli vengono concessi solo due giorni al mese…
E a queste discutibili premesse fondate su luoghi comuni sembra aggiungersene un’altra: “l’alienazione genitoriale (ovvero la manipolazione dei figli) non esiste: è una invenzione dei padri, con l’appoggio dei CTU, per togliere i figli alle madri”. Non volendo opporre opinione a opinione, basterà citare i risultati di una indagine su oltre 700 consulenze (AA. VV. “C.T.U. nei procedimenti in materia di Famiglia e Minori”, Pacini, Pisa 2022): le madri rifiutate dai figli hanno ormai raggiunto il 20% circa e si tratta di una percentuale in crescita. E a loro cosa si dovrebbe dire, che la manipolazione dei figli non esiste?
Tuttavia la Garante insiste: “… continua ad aleggiare il fantasma della cosiddetta Pas, Sindrome di alienazione parentale, costrutto stigmatizzato più volte dalla Corte di Cassazione come ascientifico e il ricorso al quale è vietato anche dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite.” Nonché: “Insisto sul tema violenza domestica perché sostanzialmente sottaciuto nel ddl che non sembra tenere conto della normativa nazionale e internazionale nonché della recentissima ordinanza
della Cassazione n. 4595 del 21 febbraio 2025, che attesta che “il tribunale civile non può trascurare le allegazioni di violenza al fine di valutare nel caso concreto il best interest del minore nonché l’idoneità del genitore a svolgere adeguatamente il suo ruolo”. Mentre prevale l’idea, in ossequio all’osservanza del principio della bigenitorialità perfetta, che anche un genitore violento può essere un buon genitore, che un conto è la violenza e un altro la capacità genitoriale, anche se sia Grevio sia la riforma Cartabia affermano che un genitore violento non può essere un buon genitore”. Dove l’ultima affermazione può essere condivisa. Tuttavia, come visto, il ddl 832 non trascura nulla: semplicemente la violenza è uno dei molti motivi di ambito penale per non investire un genitore dell’affidamento condiviso e indicarne uno solo sarebbe non solo fuori tema, ma anche pericoloso, potendo voler dire che i reati non rammentati sono irrilevanti.
No alla coordinazione genitoriale
Anche per la coordinazione la Garante invoca divieti in caso di violenza che avrebbero dovuto essere indicati, la cui mancanza esplicita si spiega esattamente come visto al punto precedente. Si può solo aggiungere che definire il coordinatore “nuova figura terza” significa dimenticare l’art. 473 bis 26 c.p.c.. Articolo che tuttavia ne dà una definizione abbastanza vaga, come la Garante giustamente lamenta. Pertanto è ancora una volta curioso che la Garante, rilevate le medesime criticità, polemizzi con un testo che si muove per sanarle.
Gli approfondimenti dei membri della Commissione e l’interesse del
minore
Interessanti sono state anche alcune delle considerazioni, o domande, venute durante l’audizione da membri della Commissione Giustizia, verso le quali la Garante si è dichiarata concorde se erano critiche e in disaccordo (o ha taciuto) se erano di apprezzamento. Ad es., è stata lamentata la possibilità che i figli siano affidati a terzi e/o messi in casa-famiglia, anche se solo per “gravi motivi”, contestando anche la mancata lista di questi. La Garante ha dichiarato di condividere la critica e che, in effetti sarebbe stato opportuno elencarli. Giova rammentare che la nostra legislazione prevede da sempre l’affidamento a terzi e che le liste sono decisamente sconsigliabili per i motivi già visti. Altro aspetto toccato è stato quello delle previsioni a favore delle madri già tali o future, verso le quali è stata espressa la preoccupazione che aumentasse il numero dei padri che avrebbero fatto ricorso al disconoscimento della paternità per risparmiare il denaro del sostegno. Evidentemente dimenticando la possibilità di ricorrere ai test del DNA.
Tuttavia, il rilievo più pesante, poiché comparso anche su diverse testate giornalistiche, riguarda il riferimento al child best interest (anche se quanto meno dovrebbe essere usata al plurale), effettivamente riconfigurata nel ddl. E’ stato detto, infatti in commissione: “Si ha l’impressione che il supremo interesse del minore che finora ha informato i provvedimenti dei magistrati rischi di attenuarsi se non addirittura di sparire davanti al principio della perfetta bigenitorialità e della pariteticità.” Rilievo malizioso (difficile dichiararsi in disaccordo, non sarebbe politicamente corretto), ma che si preoccupa ben più della forma che della sostanza. La clausola “salvo che sia contrario all’interesse del minore”, disseminata un po’ ovunque nel testo attuale, venne infatti inserita al momento del varo della legge 54/2006, allo scopo, perfettamente raggiunto, di vanificare, aggiungendola, qualsiasi diritto riconosciuto ai figli minorenni. Una formula estremamente agevole da usare, visto che nessuno ha mai definito cosa rappresenti questo interesse e cosa no. Neppure a grandi linee. Pertanto si cade nella arbitrarietà (o discrezionalità) più assoluta. Con radicali differenze da tribunale a tribunale, da giudice a giudice e perfino da vertenza a vertenza a parità di condizioni. Ovvero, nessuna certezza del diritto. Il ddl 832 nell’intento di rimediare a questa situazione ha mantenuto fermo il concetto, soltanto eliminandone la disseminazione, ma ponendolo al primo comma dell’art. 337 ter c.c. in relazione con i diritti dei figli, ovvero affermando che il riconoscimento e l’applicazione di quei diritti – ovviamente ove possibile – sicuramente corrisponde al
suo interesse. In questo senso, ne è un chiaro esempio la modifica dell’art. 473 bis 4 c.p.c. relativo alla esclusione discrezionale di un figlio dall’ascolto (art. 11 del ddl). Non a caso la Garante non ha protestato.
Per questa via il bimbo – poverino – viene da anni continuamente utilizzato strumentalmente, a tutela di tornaconti non suoi. Una vera e piena bigenitorialità – suo diritto indisponibile – gli viene negata perché “contraria al suo interesse”. Il danno e la beffa.