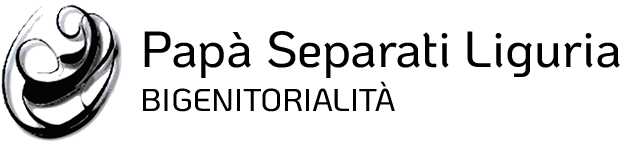Proposta di legge – Norme in materia di tutela del diritto dei minori alla bi-genitorialità

Roma_4-2-2025_Comunicato_stampa_Iniziativa_popolare
GAZZETTA UFFICIALE – DEL 5-2-2025 – CASSAZIONE – PROPOSTA LEGGE (Pagina 54).pdf
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare
Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 4 febbraio 2025, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell’art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:
«Norme in materia di tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità».
Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il comitato Genitori per i figli, via Appiani 25 – 20121 Milano email: info@comitatogenitoriperifigli.it .
25A00840
Proposta di legge – Norme in materia di tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità
Introduzione
La Legge 54 del 2006 ha introdotto finalmente in Italia, ultima tra gli Stati dotati di un sistema giudiziario avanzato, la bigenitorialità, cioè l’equilibrio e la pari dignità tra le figure genitoriali in caso di separazione, affermando con forza il principio di parità di diritti e doveri tra genitori nell’accudimento, cura ed educazione della prole. Gli strumenti normativi a supporto di questo cambiamento epocale, l’affido condiviso dei figli e il loro mantenimento equo e diretto da parte di entrambi i genitori, sono però rimasti solo parole sulla carta.
Infatti, le risoluzioni dei tribunali hanno relegato la maggior parte dei minori, inconsapevoli vittime della separazione genitoriale, nello stato di orfani con genitore in vita: secondo statistica, più del 95% delle coppie separate in Italia (che sono quasi pari alle famiglie unite) non ha un affido condiviso “equo”, con questo ponendo l’Italia al più basso posto del diritto alla bigenitorialità tra tutti i paesi industrializzati al mondo. Il privilegio per il “collocamento” dei figli, invenzione giuridica che esula dal dato normativo, è ampiamente sbilanciato verso la parte materna, pur a parità di condizioni (lavoro, orari, disponibilità, volontà di accudimento e cura) con irragionevoli aberrazioni: le asimmetrie imposte dalla prassi giudiziaria pregiudicano proprio quei minori che la legge dovrebbe tutelare, coinvolgendoli in annosi contenziosi con gravi ricadute sul loro stato di salute psico-fisica.
La normativa costituzionale e sovra-nazionale raccomanda tali principi fin dalla Convenzione di New York del 1989. In particolare, nell’anno 2015 la “Risoluzione 2079” dell’Assemblea Europea ha posto l’attenzione alla necessità di garantire la piena ed equa co -responsabilità parentale, individuando nei padri le figure ancora private della relazione con i figli. Con ciò chiedendo anche al nostro paese di rispettare il diritto paterno di essere pari all’altro genitore e di fare il massimo sforzo per dare la possibilità di un vero affidamento condiviso dei figli, nel migliore interesse di questi ultimi. Inoltre, sottolineando la co -responsabilità parentale quale essenziale contributo al fine di liberarsi dagli stereotipi di genere che riguardano i ruoli socialmente assegnati alla donna e all’uomo che riverberano la ripartizione di compiti in seno alla famiglia.
Famiglia che i tribunali italiani, ancorati a logiche patriarcali, individuano ancora come costituita da un genitore debole ma prioritario, la donna, alla quale vanno tutti i diritti e i doveri di cura e accudimento, di fatto impedendone l’emancipazione, la libertà e la realizzazione sociale nel mondo del lavoro.
La distorta declinazione in Italia della Legge 54 nei tribunali italiani ha portato sul nostro paese l’occhio vigile dell’Europa che, tramite la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sanziona l’Italia ripetutamente da anni, condannando il nostro paese a ingenti risarcimenti.
Non di meno, anche recentissimi studi indipendenti hanno sottolineato che i figli dei separati in Italia sono i più infelici di tutta Europa (“Joint physical custody of children in Europe” in Demographic Research 2023).
Questi nodi e la loro soluzione o miglior accomodamento sono il focus di questa proposta di legge a vent’anni dalla Legge 54 i cui risultati sono stati, con massima evidenza, fallimentari. Ne è evidenza l’enorme numero di cause civili e non solo in ambito familiare che affliggono il sistema giudiziario. Parliamo di milioni di casi che rallentano l’evoluzione dell’intero Paese, e ostruiscono il processo di sviluppo del nucleo sociale della famiglia, fondamento della base costituzionale, anche in termini di parità tra i sessi/generi, per non parlare degli esorbitanti costi e oneri per il sistema.
Questa proposta – come detto – segue e rispetta tutti i dettami della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176.
Nel dettaglio dei tredici articoli proposti, poniamo l’attenzione sui singoli punti che identificano peculiarmente il disegno e il suo contesto.
L’Articolo 1 sottolinea con riferimento netto e preciso i richiami costituzionali (Artt. 2-3 29-30 Cost) e i diritti del cittadino al rispetto della vita familiare da parte dello Stato. Richiama con forza il fondamentale principio dell’eguaglianza tra i genitori quale persone inserite in un contesto sociale e, soprattutto, nei rapporti con i figli. In ogni condizione familiare, lo Stato garantisce pari diritti e doveri a entrambi i genitori permettendo loro di poter esplicare il diritto alla genitorialità e alla relazione familiare in maniera libera e piena, senza limitazioni da parte dello Stato, promuovendo tutte le azioni possibili affinché questo avvenga, nell’interesse primario dei minori. Lo strettissimo legame con i dettami della Carta costituzionale e con la normativa sovra nazionale di riferimento non possono e non devono essere dimenticati nell’interpretazione e applicazione delle norme da parte degli Organi preposti.
L’Articolo 2 si occupa nello specifico del rapporto tra genitori e figli. Le novità rispetto al precedente 337-ter CC riguardano la promozione definitiva del diritto e dovere di paritetico impegno nell’accudimento da parte di entrambi i genitori e la paritetica assunzione di responsabilità genitoriale, talché i figli, in mancanza di oggettivi e comprovati motivi ostativi o impedimenti, possano trascorrere pari tempi per fruire di apporti educativi e cura da parte di entrambe le figure genitoriali. Il piano genitoriale diventa importante strumento per regolare e seguire, nel corso del tempo, la crescita dei minori e stabilire le migliori alternanze di frequentazione tra genitori e figli in modo da minimizzare i disagi fatalmente derivanti dalla separazione abitativa dei genitori delineando un prospetto pratico, applicabile con semplicità e chiarezza. Ciò è di fondamentale importanza in quanto allo stato non esiste una norma chiara o di prassi consolidata che parifichi con chiarezza le responsabilità e gli impegni verso i figli di entrambi i genitori. È altresì individuato il criterio del mantenimento diretto come quello più appropriato a garantire equilibrio contributivo e la presenza di un fondo alimentato da entrambi i genitori da cui attingere per le spese relative ai figli, con rendicontazione reciproca e con regole di trasparenza definite.
L’Articolo 3 concerne la destinazione della casa familiare a seguito della separazione abitativa dei genitori. La nuova formulazione dell’art. 337 sexies c.c. è tesa a favorire e stimolare l’accordo economico complessivo dei genitori e l’assunzione di responsabilità condivise nel momento in cui essi decidono di separarsi, evitando che il privilegio dell’assegnazione susciti o fomenti il contenzioso giudiziario, con pesanti ricadute in termini di benessere dei figli. La risoluzione di tale fondamentale tema, che in Italia viene oggi trattato in maniera singolare tra i Paesi avanzati, è funzionale alla gestione di una separazione meno conflittuale con attenzione anche ai diritti economici delle parti coinvolte.
Il concetto di conservazione della casa familiare quale habitat logistico e non come centro degli affetti, oltre a stridere fortemente con i principi di bigenitorialità promossi dalla riforma del 2006, non ha un reale fondamento scientifico e fattuale, ed è sconfessato dai più avanzati studi e meta-studi internazionali in materia psicologico-relazionale e della famiglia. In tale contesto la tutela del best-interest della prole è adeguatamente contemperata con la protezione del diritto costituzionale di proprietà della casa familiare, e nella proposta normativa in discorso, vengono comunque rafforzate le tutele economiche per il genitore più debole che non ha a disposizione una abitazione dove vivere con i figli nei suoi tempi di accudimento della prole. In via solamente residuale, ovvero quando entrambi i genitori non possono o non vogliono trovare autonome sistemazioni, rimane al giudice la possibilità di assegnare la casa, ma solo ai figli stessi, determinandovi così l’alternanza dei genitori nei periodi di accudimento dei figli secondo il piano genitoriale. Infine, viene ribadito con fermezza che ogni mutamento unilaterale di residenza dei figli non è accettabile, e che tale mutamento deve essere concordato dai genitori, questo per porre un freno agli illegittimi allontanamenti de facto che sono purtroppo frequentemente agiti su base nazionale e internazionale, in maniera anche violenta.
L’Articolo 4 pone fine alle distorsioni applicative di cui approfittano figli ormai adulti e formati che continuano a sfruttare gli obblighi di mantenimento da parte dei genitori in maniera poco responsabile, ciò che non favorisce il raggiungimento della loro autonomia di vita in tempi ragionevoli. Appare dunque opportuno cercare di limitare ogni forma di cosiddetto “bamboccismo” e di parassitismo di persone oramai adulte verso le sostanze economiche e le risorse dei genitori. Viene indicato il limite del mantenimento ai 19 anni a meno di frequenza proficua di studi universitari o simili, ma non oltre i 26 anni.
L’Articolo 5 aggiunge la conformità all’Articolo 337-ter CC e seguenti in merito ai provvedimenti riguardo ai figli.
L’Articolo 6 delinea i limiti entro cui ha validità una Consulenza tecnica d’ufficio e l’azione degli operatori dei Servizi sociali di strutture pubbliche, indicando in particolare la necessità che tali indagini non possano esulare dalle domande poste dal giudice e in ogni caso non possano dare indicazioni di sorta su regime affidatario, frequentazione con i genitori e domicilio.
L’Articolo 7 e l’Articolo 8 si occupano di tutelare i minori da sottrazioni nazionali e internazionali, indicando le condizioni e le pene.
L’Articolo 9 e l’Articolo 10 fronteggiano le cosiddette false accuse, pratica diffusissima (oltre il 90% delle accuse di violenza o molestia in fase di separativa risultano false, da un punto di vista statistico) e comunemente usata per pressioni sull’altra componente genitoriale, per vantaggi prettamente economici e di godimento di beni. Di fatto questo genera uno sbilanciamento sul piano giudiziale di fronte al tribunale, con procedimenti che possono durare anche anni per i quali, come noto, la quasi totalità risulta finzione strumentale.
L’Articolo 11 nasce dalla necessità di riconoscere e contrastare lo “stalking” genitoriale, ovvero il malsano comportamento atto a contrastare la frequentazione con i figli con l’altro genitore, individuando pene chiare ed efficaci. La problematica è stringente in quanto numerose coppie di genitori separati spesso usano i figli come mezzi per la loro conflittualità manipolandoli nella relazione e impedendo loro, volenti per pressione psicologica o nolenti, la regolarità della frequentazione con l’altro genitore.
L’Articolo 12 afferma i termini di applicabilità ai giudizi pendenti, e il monitoraggio della applicazione della normativa da parte del Mistero della giustizia.
L’Articolo 13 conferma l’invarianza finanziaria.
Norme in materia di tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità
Art. 1. (Principi generali)
1. In conformità agli artt. 3 e 30, comma 1, della Costituzione, la Repubblica riconosce l’importanza del ruolo di entrambi i genitori nelle diverse fasi della crescita psico-fisica dei figli e, anche nel caso in cui i genitori vivano separati, promuove tutte le azioni necessarie a garantire un rapporto paritetico della prole con il padre e la madre, tutelando e promuovendo la parità nell’accudimento, cura ed educazione dei figli.
Art. 2. (Modifica dell’articolo 337-ter del Codice Civile)
1. L’articolo 337-ter del Codice Civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli) – Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale.
Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi e debitamente comprovati, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Nel valutare la permanenza presso ciascun genitore, dovranno essere indicati obbligatoriamente nel piano genitoriale anche gli orari lavorativi di ciascun genitore, per poter favorire un accordo su base bisettimanale che permetta l’organizzazione in base agli impegni scolastici del minore e alle altre attività indicate nel piano genitoriale nell’interesse del minore. Ognuno dei genitori è libero di avvalersi del sostegno di figure esterne per la cura e l’accudimento della prole, da scegliersi preferibilmente nell’ambito della cerchia parentale. In caso di disaccordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre.
Il giudice o le parti, quando le circostanze rendano difficile attuare una divisione paritaria dei tempi su base mensile, devono prevedere adeguati meccanismi di recupero dei tempi durante i periodi di vacanza del minore, al fine di garantire una sostanziale equivalenza dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso dell’anno.
Il figlio minore ha inoltre il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Gli ascendenti del minore possono intervenire nei giudizi relativi ai minori con le forme dell’articolo 105 del codice di procedura civile.
Il giudice, salvo che ciò sia contrario al superiore interesse del minore, affida in via condivisa i figli minori a entrambi i genitori e stabilisce il doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute. La residenza sarà assegnata presso uno dei genitori a meri fini anagrafici.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni quotidiane sono assunte dal genitore che in quel momento si trova col figlio minore, mentre quelle di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.
Nel piano genitoriale deve essere indicata la misura con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito e patrimonio, considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) le risorse economiche di entrambi i genitori;
3) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il giudice prende atto, se non contrari al superiore interesse del minore, degli accordi intervenuti tra i genitori, anche all’esito di un procedimento di mediazione familiare. In mancanza di accordo o in caso di accordo parziale, il giudice, sentite le parti, recepisce quanto parzialmente concordato dai genitori e determina comunque i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, applicando in ogni caso il criterio del mantenimento diretto, sulla base del costo medio di beni e servizi necessari per i figli, individuato su base locale.
Quando le circostanze rendano difficile attuare una divisione paritaria dei tempi su base mensile a causa di ostacoli oggettivi, ciascun genitore è tenuto a provvedere al mantenimento del figlio, istituendo un fondo comune a ciò destinato, in cui entrambi i genitori provvederanno a versare le somme determinate dal giudice sulla base delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, secondo quanto previsto dall’art. 473-bis.12 del codice di procedura vivile, per garantire che l’obbligo di mantenimento della prole sia distribuito in maniera equilibrata fra i due genitori. Il genitore che attinge al fondo dovrà obbligatoriamente rendere all’altro il conto delle spese ordinarie e straordinarie, dimostrando l’impiego del fondo esclusivamente a beneficio esclusivo della prole.
In caso di violazione degli obblighi di natura economica a carico di uno dei genitori, si applica l’articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898».
Art. 3. (Modifica dell’art. 337-sexies del Codice Civile)
L’articolo 337-sexies del Codice Civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-sexies. Godimento della casa familiare. – In caso di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, il godimento della casa familiare è definito in base al titolo di proprietà, ovvero ad altro idoneo titolo ad effetto reale o obbligatorio. Il giudice potrà stabilire un contributo a fini abitativi a carico di un genitore, nel caso in cui l’altro sia privo di mezzi economici sufficienti a garantire alla prole adeguate condizioni di vita nel tempo in cui la stessa dimori presso di lui.
L’eventuale assegnazione della casa familiare potrà essere disposta solo a favore dei figli, prevedendo che i genitori vi si alternino secondo i periodi di custodia della prole concordati tra di loro, o stabiliti dal giudice.
Ogni cambiamento di residenza del figlio minore deve essere, a pena di irricevibilità della richiesta, preventivamente concordato per iscritto da entrambi i genitori o da tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale».
Art. 4. (Modifica dell’articolo 337-septies del Codice Civile)
1. L’articolo 337-septies del Codice Civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-septies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni. – Il giudice, in caso di disaccordo tra le parti, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico, il cui ammontare complessivo va ripartito a metà tra i genitori. Tale assegno è versato direttamente al figlio, fermi per quest’ultimo gli obblighi di cui all’articolo 315-bis.
Ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nei confronti dei figli maggiorenni cessa l’obbligo di mantenimento in capo ad entrambi i genitori al compimento del diciannovesimo anno di età del figlio. Tale obbligo può persistere oltre tale momento soltanto in caso di proficua frequenza di studi universitari, e comunque non oltre la data del compimento del ventiseiesimo anno di età».
Art. 5. (Modifica all’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132)
1.All’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli 337-ter e seguenti del Codice Civile».
Art. 6. (Introduzione dell’art. 337-novies del Codice Civile)
1. Al Titolo IX del Capo II del Libro I del Codice Civile, dopo l’articolo 337-octies è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 337-novies. – (Consulenze tecniche e indagini del servizio sociale professionale territoriale) – Solo qualora sia strettamente necessario all’emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 337-ter e 337-quater, il giudice, con provvedimento puntualmente motivato, tenendo prioritariamente conto dell’interesse del figlio a non subire le conseguenze della conflittualità dei genitori e di non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la loro volontà legalmente espressa, può avvalersi di un consulente tecnico, ovvero dei servizi sociali professionali territorialmente competenti e delle strutture ospedaliere pubbliche, esclusivamente per l’accertamento delle competenze genitoriali. Le risposte ai quesiti posti dal giudice fornite dal consulente tecnico nominato d’ufficio o dagli operatori dei Servizio Sociali o delle strutture ospedaliere pubbliche non possono contenere suggerimenti su regime di affidamento, domiciliazione, modalità di frequentazione e tempi di permanenza del minore presso i genitori.
Le indagini e gli approfondimenti di cui al comma 1 devono sempre svolgersi nel rispetto del diritto di difesa e al contraddittorio di tutte le parti. Si applicano integralmente le disposizioni di cui agli articoli 62, 192, 194, 195, 196, 197 e 201 del codice di procedura civile».
Art. 7. (Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis del Codice di Procedura Penale)
Gli articoli 574 e 574-bis del Codice di Procedura Penale sono abrogati.
Art. 8. (Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci)
1. Dopo l’articolo 605 del Codice di Procedura Penale è inserito il seguente:
«Art. 605-bis. (Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci). –
Chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 316 del Codice Civile, al tutore di cui all’articolo 346 del Codice Civile, al curatore di cui all’articolo 424 del Codice Civile, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene, o lo conduce o lo trattiene all’estero, contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi sottrae o trattiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
Nel caso in cui la sottrazione avvenga a fini di lucro, si applicano le pene previste dall’articolo 630.
Per il reato di cui al primo, al secondo e al terzo comma non si tiene conto delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis del presente codice, ai fini dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale».
Art. 9. (Accuse false o infondate di abusi o maltrattamenti in famiglia)
1. Dopo l’art. 337-novies del Codice Civile è introdotto il seguente:
«Art 337-decies. Accuse false o infondate. –
Il giudice dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore che abbia allegato in giudizio fatti costituenti abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere ovvero altri reati ai danni dell’altro genitore o del figlio che, anche all’esito di una sommaria istruttoria, siano risultati insussistenti».
Art 10. (Modifica dell’art. 368 del Codice di Procedura Penale)
All’art. 368 del Codice di Procedura Penale sono aggiunti i seguenti commi:
- Le pene sono aumentate di un terzo per il coniuge, l’ex coniuge, il convivente, l’ex convivente o comunque il genitore che con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato l’altro genitore che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato”;
- La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di ottenere nei confronti dell’altro genitore un ingiusto vantaggio o un altrui detrimento nelle condizioni di affidamento e mantenimento della prole
Art. 11. (Introduzione dell’articolo 570-ter del Codice di Procedura Penale)
Dopo l’articolo 570 bis del Codice di Procedura Penale è introdotto il seguente:
Art. 570-ter (Stalking genitoriale)
-
Chiunque, abusando dell’affidamento di un minorenne, indebitamente limita, impedisce o nega al genitore non affidatario il suo diritto di frequentarlo, istruirlo ed educarlo è punito con la reclusione fino ad un anno.
-
La pena è della reclusione da 2 a 4 anni nel caso in cui l’autore interrompa senza giustificato motivo per un periodo superiore ai tre mesi la continuità della relazione del genitore non affidatario col figlio minore.
-
In caso di gravi e ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il giudice può applicare la pena accessoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Art. 12. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 della presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.
2. Entro il mese di febbraio, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione della perdita del diritto alla bi-genitorialità in capo ai minori.
Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.